Tommaso Guardati, in arte Masuccio Salernitano (Salerno, 1410 – Salerno, 1475), è da ricordare come uno dei maggiori esempi di letteratura salernitana e campana del XV secolo. Nato sotto il Regno angioino, visse poi a stretto contatto con la corte aragonese (a partire dal 1442 con Alfonso d’Aragona).
Contribuì alla crescita e al risanamento culturale e intellettuale del Mezzogiorno, insieme alla cerchia di innumerevoli umanisti che il Magnanimo volle attorno a sé.

Masuccio Salernitano: la formazione e la carriera
La formazione culturale e letteraria di Masuccio, però, si deve in parte all’ambiente circoscritto e limitato dove nacque e iniziò gli studi: il Principato di Salerno.
Fin da giovanissimo, Masuccio fu lì a contatto con una realtà basata principalmente su relazioni familiari tra feudatari e attività agricolo-pastorali. Nei suoi testi, infatti, affrontò spesso problemi socio-ambientali, economici e politici appartenenti alla sua città.
Masuccio e il rapporto con Salerno
A Salerno, Masuccio visse molto probabilmente l’esperienza dello ‹‹Studium››, un’università vera e propria, dove, oltre alla fisica e alla filosofia aristotelica, si studiava grammatica e retorica.
Già verso la metà del XIV secolo l’università era diventata un’istituzione per la città. Particolarmente nota a Salerno era anche la Scuola Medica, dove, accanto alla ricerca medico-chirurgica, veniva offerta una formazione culturale-letteraria di stampo realistico e laico.
Così, influenzato dall’ambiente e dalla cultura salernitana, Masuccio incominciò a scrivere le cinquanta novelle che costituirono il suo Novellino. Vi troviamo riflessioni su esperienze umane, sociali e culturali vissute prima dell’incontro con la società aragonese. Non mancano, poi, elementi quali il realismo, la liceità, la disinibizione, il misoginismo e la polemica anti-ecclesiastica che solo in una città culturalmente e socialmente emancipata come Salerno Masuccio avrebbe potuto apprendere. Il suo legame con le proprie origini fu tale che preferì addirittura esser conosciuto presso il mondo culturale con il toponimo Salernitano piuttosto che con il proprio cognome.
Masuccio e il rapporto con Alfonso I di Napoli
Una svolta nella carriera letteraria di Masuccio fu l’avvicinamento ad Alfonso I Re di Napoli. Questi fu promotore di una rinascita artistica e letteraria nella capitale del regno. Partecipava ai dibattiti e agli studi che gli intellettuali della corte tenevano quotidianamente. Alfonso I, infatti, pur non essendo realmente interessato alla letteratura, comprese che, per legittimare e rafforzare il suo potere al trono, doveva rivestire i panni del mecenate incline a promuovere attorno a sé le più brillanti attività e iniziative umanistiche dell’epoca.
Il Novellino
L’opera alla quale Masuccio lavorò prima e durante il periodo presso la corte aragonese fu “Il Novellino“, pubblicato postumo nel 1476. La raccolta è divisa in cinque parti. Ciascuna di esse si incentra su uno specifico tema ed è costituita da dieci novelle, per un totale di cinquanta brevi racconti. Essi sono dedicati soprattutto al mondo della corte napoletana. Masuccio intendeva proporre dei valori cortesi al fine di migliorare eticamente l’ambiente. Ogni novella, infatti, si conclude con un commento morale proposto da Masuccio stesso.
Il Novellino e il Decameron
È indubitabile il legame fra il Novellino e il Decameron di Boccaccio, altro elemento che testimonia l’influenza che la cultura salernitana ebbe su Masuccio: a Napoli, centro dell’umanesimo del Mezzogiorno, si prediligeva infatti lo studio di testi classici latini e greci, piuttosto che opere in volgare di carattere popolaresco.
Salerno, invece, rimase più legata alla tradizione medioevale, diffondendo la lettura di testi come il Decameron. Soltanto col regno di Ferrante (1458-1494), la letteratura popolare in volgare fu apprezzata a corte, e da quel momento in poi, l’opera di Masuccio ottenne i meriti che fino ad allora non gli erano stati riconosciuti (svariate novelle erano state pubblicate singolarmente e senza successo fra il 1450 e il 1457).
Nei suoi racconti, Masuccio mostrò consapevolezza della crisi e della decadenza morale, della necessità di creare una nuova cultura e di trovare soluzioni ai problemi sociali e di corte. Con pungente ironia, nelle vesti di un moralista laico, il Salernitano polemizzò contro i costumi del tempo (specialmente contro quelli della Curia).
Si può annoverare, dunque, Masuccio tra i principali autori dell’Umanesimo campano che proposero un risanamento culturale, intellettuale, politico e specialmente morale della società, attraverso il mezzo più potente che un uomo del ‘400 potesse avere: la scrittura.

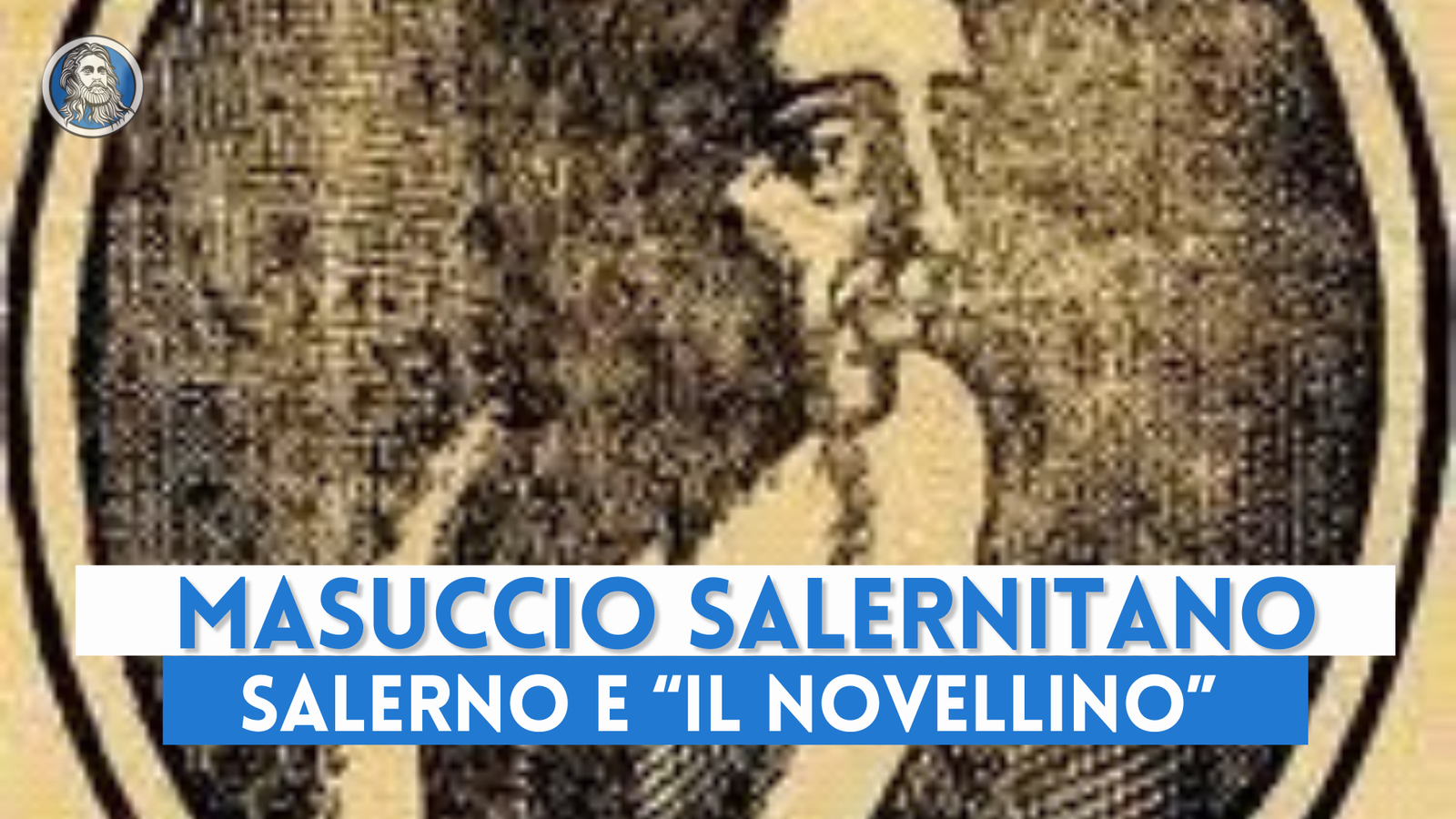
Lascia un commento