Nell’estate del 1246, le dolci colline del Cilento furono testimoni di uno dei capitoli più cruenti della storia medievale italiana. Quello che oggi è un territorio incantevole, patrimonio UNESCO, divenne il palcoscenico di una vendetta imperiale che avrebbe lasciato il segno per generazioni. La congiura di Capaccio non fu solo un episodio di tradimento politico, ma un vero e proprio spartiacque che ridisegnò gli equilibri di potere nel Mezzogiorno.
Quando l’imperatore divenne il “mostro”
Federico II di Svevia, quello che i contemporanei chiamavano “stupor mundi” (lo stupore del mondo), aveva trasformato la Sicilia in un laboratorio di modernità. Alla corte di Palermo si parlava in arabo, greco, latino e volgare. L’imperatore aveva fondato l’Università di Napoli nel 1224, aveva introdotto il diritto romano nel suo regno e manteneva corrispondenze diplomatiche con il sultano d’Egitto. Eppure, nell’estate del 1246, questo stesso sovrano illuminato si trasformò in un carnefice spietato.
La ragione di questa trasformazione va cercata nel rapporto tormentato con la Chiesa. Papa Innocenzo IV, eletto nel 1243 dopo due anni di sede vacante, aveva dichiarato Federico “apostata e traditore” durante il Concilio di Lione del 1245. Ma c’era di più: dalla cancelleria papale era partito un ordine di assassinio contro l’imperatore. Quando Federico scoprì il complotto, la sua reazione fu terribile quanto metodica.

Il castello dove morì la nobiltà italiana
Il castello di Capaccio, oggi suggestivo rudere che domina la piana del Sele, nell’aprile del 1246 sembrava una fortezza inespugnabile. I nobili congiurati vi si erano rifugiati credendo di essere al sicuro. Tra loro c’erano i Fasanella, i Morra, i Sanseverino: nomi che per secoli avevano fatto la storia del Mezzogiorno. Riccardo Sanseverino di Caserta, uno dei più fidati consiglieri dell’imperatore, aveva tradito il suo signore per denaro papale.
L’assedio durò tre mesi. I soldati federiciani, con una strategia tanto semplice quanto efficace, sabotarono le cisterne dell’acqua. Il caldo torrido di luglio fece il resto. Quando i 150 nobili si arresero, probabilmente non immaginavano quale destino li attendesse.
La vendetta dei quattro elementi
Federico aveva introdotto nel suo regno la “lex pompeia”, l’antica legge romana contro i parricidi. Secondo questa norma, chi si macchiava di tale crimine doveva essere punito con tutti e quattro gli elementi naturali: terra, acqua, aria e fuoco. L’imperatore considerò i traditori alla stregua di figli che avessero ucciso il padre, e applicò la legge alla lettera.
Le cronache dell’epoca, raccontate dal letterato di corte Terrisio d’Atina, descrivono scene agghiaccianti. Alcuni nobili furono legati ai cavalli e trascinati fino alla morte “per quella stessa terra che avevan voluto cospargere di sangue innocente”. Altri furono chiusi in sacchi e gettati in mare perché “avevan voluto propinare ai fedeli il calice dell’amarezza”. Altri ancora finirono impiccati o bruciati vivi.
Le torture atroci di Tebaldo Francesco
Ma fu il destino di Tebaldo Francesco a impressionare maggiormente i contemporanei. Questo nobile aveva raggiunto le più alte cariche nell’Italia settentrionale grazie alla fiducia dell’imperatore. Federico II gli fece inchiodare sulla fronte la lettera papale che lo esortava al tradimento, poi lo fece accecare, mutilare di naso, braccia e gambe. Quello che restava di Tebaldo fu caricato su un carro che girò di città in città, con un proclama che invitava tutti a “guardare quest’uomo mostruoso” come monito per il futuro.
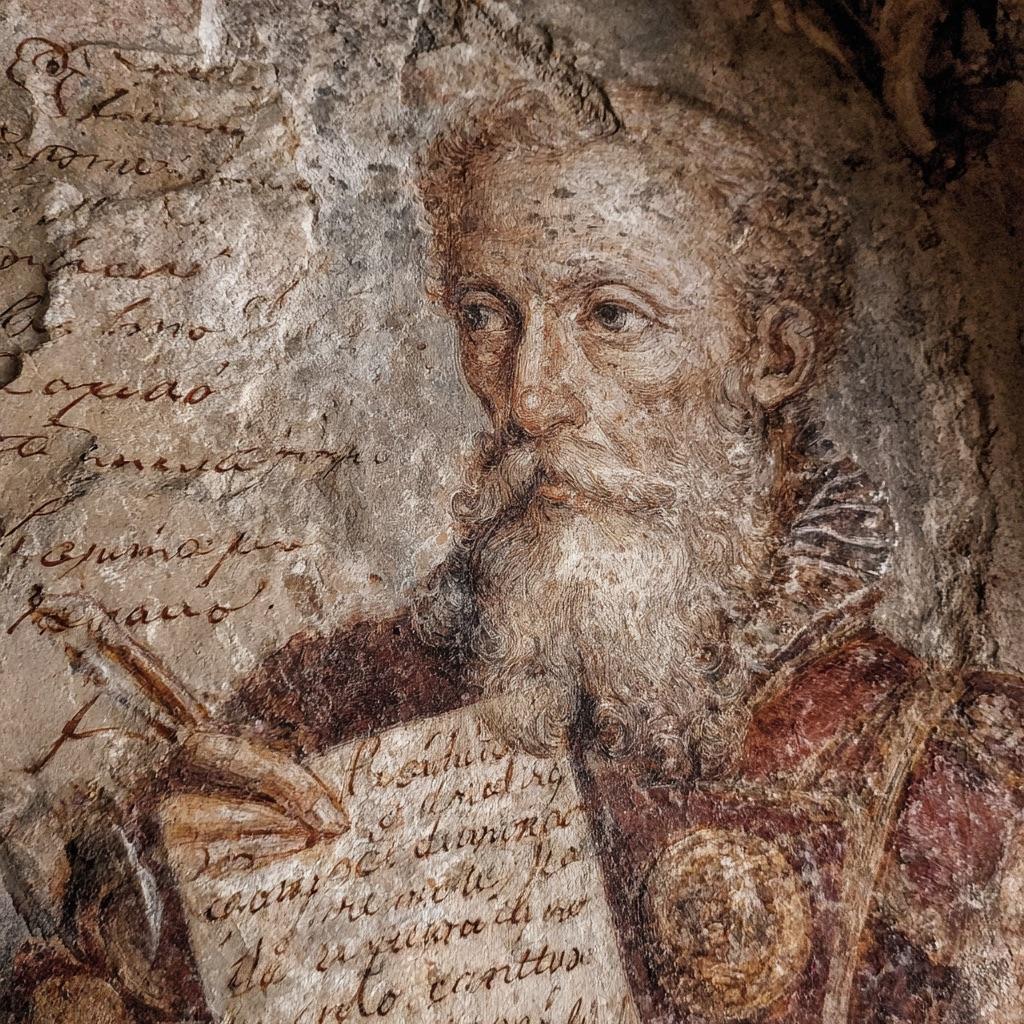
Un territorio che porta ancora i segni
Il Cilento pagò un prezzo altissimo. Molte delle più importanti famiglie nobiliari del territorio furono decimate. I castelli di Sala Consilina e Altavilla Silentina caddero rapidamente nelle mani dell’esercito imperiale. Secondo alcune fonti, Federico vendette come schiave anche le donne trovate nel castello di Capaccio, una pratica che testimonia la durezza dei tempi.
Alcuni riuscirono a fuggire: Pandolfo di Fasanella e Giacomo di Morra trovarono rifugio a Roma, dove si misero al servizio del papa che aveva orchestrato la congiura. Ma per la maggior parte dei traditori non ci fu scampo.
L’eredità di una vendetta
La congiura di Capaccio segnò un punto di non ritorno nei rapporti tra Federico II e la Chiesa. L’imperatore morì quattro anni dopo, il 13 dicembre 1250, in circostanze mai del tutto chiarite. Con lui si spense non solo un sovrano, ma un’intera epoca.
Oggi, passeggiando tra i ruderi del castello di Capaccio o attraversando i borghi del Cilento, è difficile immaginare che questi luoghi furono teatro di tanta violenza. Eppure, la storia di quella terribile estate del 1246 ci ricorda come anche i sovrani più illuminati potessero trasformarsi in tiranni quando si sentivano traditi. Federico II rimane nella storia come lo “stupor mundi”, ma anche come l’imperatore che insegnò al mondo medievale cosa significasse sfidare il potere assoluto.
La vendetta di Capaccio non fu solo un episodio di crudeltà: fu il tentativo di un sovrano di ristabilire un ordine che sentiva minacciato dalle macchinazioni papali. Un tentativo che, paradossalmente, contribuì a minare per sempre la sua immagine presso i posteri.
Bibliografia e fonti
- Congiura di Capaccio (1246) – Enciclopedia Treccani, Federiciana: https://www.treccani.it/enciclopedia/congiura-di-capaccio_%28Federiciana%29/
- Federico II, lo stupor mundi – Storica National Geographic: https://www.storicang.it/a/federico-ii-stupor-mundi_14986
- Concilio di Lione I – Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Lione_I
- Le terrificanti esecuzioni dei Nobili della Congiura di Capaccio – Vanilla Magazine: https://www.vanillamagazine.it/le-terrificanti-esecuzioni-dei-nobili-della-congiura-di-capaccio/

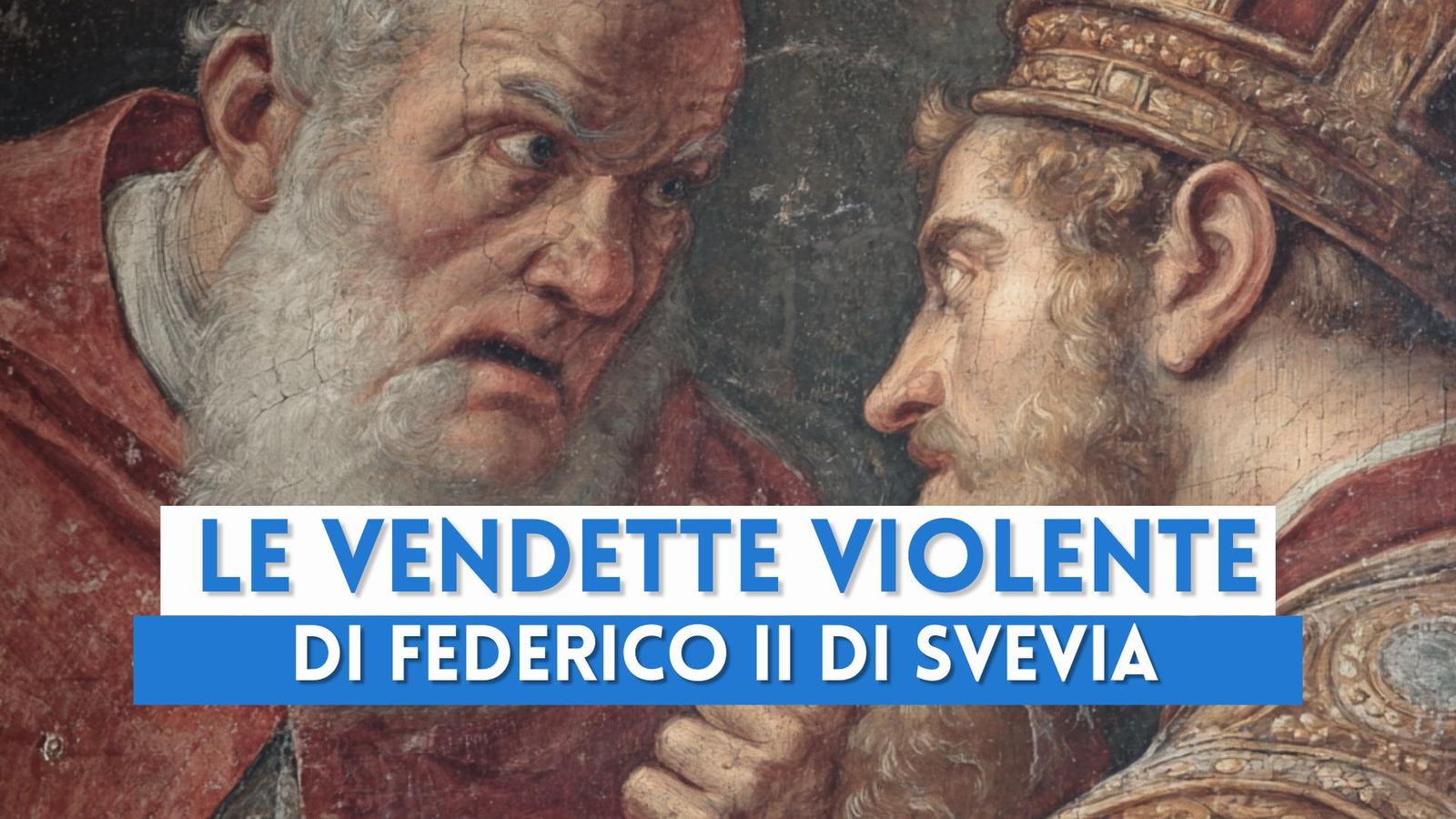
Lascia un commento