Immaginate una città così antica da aver visto nascere l’alfabeto che state usando per leggere queste parole. Una colonia greca che ha sfidato i secoli, resistito agli assedi e custodito i segreti della misteriosa Sibilla. Questa città esiste davvero e si chiama Cuma, la più antica colonia greca d’Occidente, un gioiello archeologico incastonato nei Campi Flegrei, a pochi chilometri da Napoli.

Le origini leggendarie
La storia di Cuma inizia nell’VIII secolo a.C., quando coloni provenienti dall’isola di Eubea, guidati da Megastene di Calcide e Ippocle di Cyme, decisero di abbandonare la loro prima sede sull’isola d’Ischia per cercare fortune migliori sulla terraferma. Secondo il racconto di Velleio Patercolo, la loro flotta seguì il volo di una colomba o, secondo altre versioni, fu guidata durante la notte dal suono del sacro bronzo usato nelle feste di Cerere.
La tradizione vuole che la fondazione risalga al 740 a.C., rendendo Cuma la più antica colonia greca d’Occidente, ancora più antica delle celebri colonie della Sicilia e della Magna Grecia, come confermato da Strabone quando scriveva: “est enim antiquissima haec urbs omnium Sicularum et Italicarum a Graecis deductarum coloniarum”.
Un Nome, Mille Leggende
L’origine del nome Cuma è avvolta nel mistero e nelle leggende. Secondo Agazia e Servio, alcuni sostengono che la città prese il nome da una donna incinta che i coloni incontrarono al loro primo sbarco. Altri credono derivi dalle onde del mare (kýma in greco). Il Capaccio offre una spiegazione poetica: “Cumas quietem significat, cum post tot maris labores in eo tandem colle quiescerint” – Cuma significa quiete, perché dopo tante fatiche del mare, finalmente riposarono su quel colle.
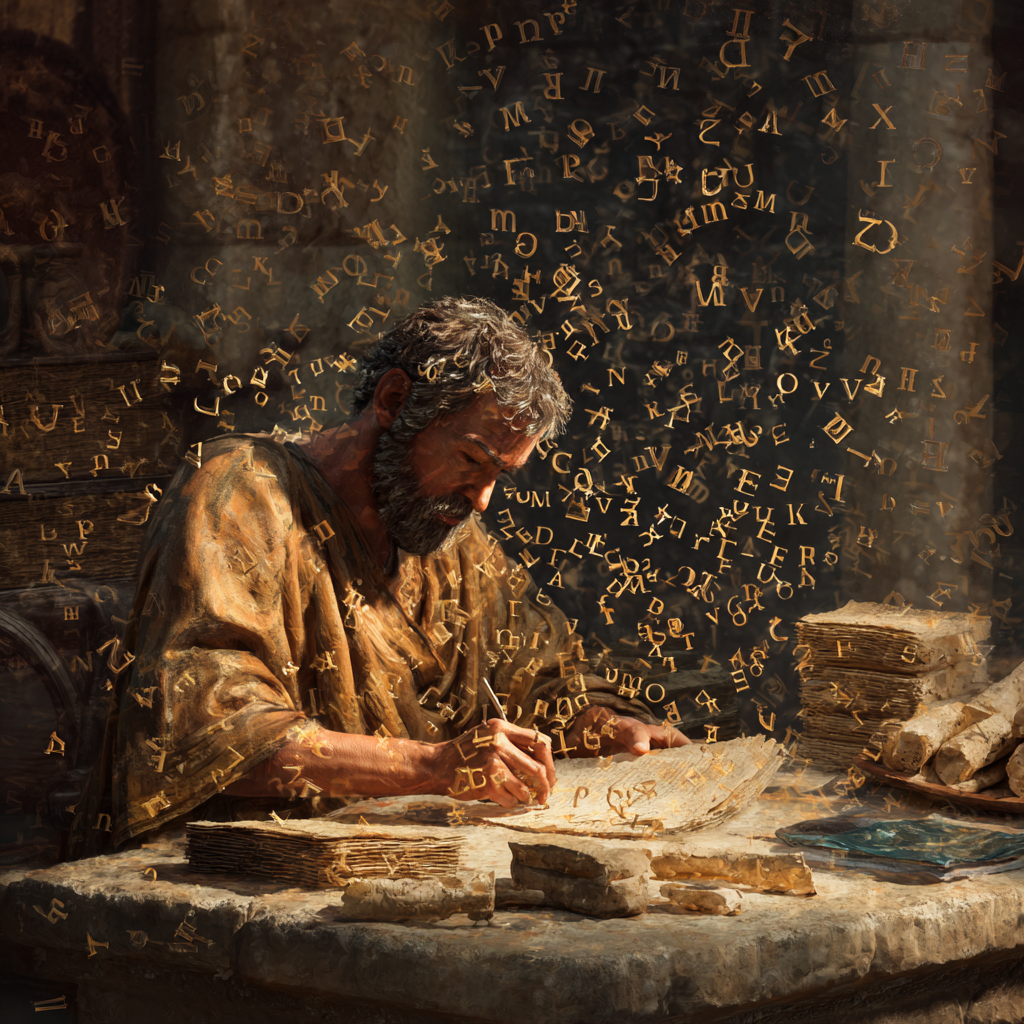
La Posizione Strategica
I coloni scelsero con sapienza la loro nuova dimora: un promontorio vulcanico che si innalza come una sentinella nella vasta pianura campana, a circa sei miglia dall’attuale Pozzuoli. La posizione era strategicamente perfetta: tagliato a picco su tre lati (levante, ponente e settentrione), il colle era praticamente inespugnabile, accessibile solo dal lato meridionale. Come descrive magistralmente Dione Cassio, Cuma era circondata da tre seni marini: il Tirreno, il Lucrino e l’Averno, rendendo la città una vera fortezza naturale.
L’Età dell’Oro e le Grandi Battaglie
Nel VII e VI secolo a.C., Cuma visse la sua età dell’oro. Il dominio cumano si estese rapidamente a tutta la regione flegrea, controllando i porti naturali di Capo Miseno e l’intero golfo di Pozzuoli. La città fondò persino Neapolis (Napoli), stabilendo un’effettiva egemonia su tutto il litorale campano.
Ma la ricchezza attira sempre nemici. Nel 524 a.C., una coalizione di Etruschi, Dauni, Umbri e altri popoli barbarici, con un esercito di 50.000 fanti e 18.000 cavalli, marciò contro Cuma per impadronirsi del suo fertile territorio. I Cumani, con appena 600 cavalieri e 4.500 fanti, divisero le loro forze in tre parti: una a difesa della città, una di riserva e una schierata fuori dalle mura per affrontare il nemico.
La battaglia fu epica. I barbari, sicuri della loro superiorità numerica, attaccarono senza ordine, mescolando fanti e cavalieri, lanciando grida selvagge. Ma il terreno, chiuso da strette valli, monti e laghi, favorì la virtù dei Cumani e danneggiò i barbari. La vittoria cumana fu totale e diede origine alla leggenda dei Giganti domati da Ercole nei Campi Flegrei.
Il Dono dell’Alfabeto al Mondo
Uno degli aspetti più straordinari di Cuma è il suo contributo fondamentale alla civiltà occidentale. La città introdusse l’alfabeto calcidese in Italia, che venne poi adottato dagli Etruschi, modificato dai Romani e trasformato nell’alfabeto latino che usiamo ancora oggi. In sostanza, ogni volta che scriviamo, rendiamo omaggio all’antica Cuma.
Declino e Rinascite
La fortuna di Cuma non durò per sempre. Nel 421 a.C., ammolliti dai piaceri e dalle ricchezze, i Cumani furono sconfitti dai Campani (abitanti di Capua), che misero la città a sacco, cacciarono gli abitanti in schiavitù e dedussero una colonia campana in quella che era stata una gloriosa città greca.
I pochi Cumani sopravvissuti si rifugiarono a Napoli, dove furono accolti con amorevolezza. Quando Roma conquistò la Campania, Cuma divenne prima un municipium sine suffragio (senza diritto di voto), poi colonia militare sotto Augusto.

L’Epoca del Basso Impero e le Ultime Battaglie
Durante il periodo del basso impero, Cuma rimase una delle cittadelle meglio fortificate della Campania. La città visse ancora momenti di gloria militare: nel 536 d.C. fu occupata da Belisario, ripresa da Totila nel 542 e nuovamente conquistata da Narsete nel 553.
Un episodio curioso riguarda Totila, il re goto che, trovando nella città alcune donne patrizie romane, non solo le fece rispettare ma le rimandò onorevolmente alle loro famiglie, guadagnandosi fama di principe savio e benigno.
La Fine di un’Era
Il colpo finale arrivò nel 1207, quando le armate napoletane distrussero definitivamente Cuma. La storia racconta che verso il 1134 esisteva ancora un “Castrum Cumanum” posseduto da Guglielmo de Prioldo, ma ormai la gloriosa città era ridotta a un semplice castello.
L’ultimo drammatico episodio si verificò quando Goffredo Gentile, conte di Lesina, si alleò con i Napoletani per conquistare il castello. Dopo aver giurato che avrebbe consegnato uomini e beni se la fortezza fosse caduta, entrarono insieme nella città e la distrussero completamente, spianando abitazioni e fortificazioni fino alle fondamenta.

Tesori Archeologici e Curiosità
Oggi, i resti di Cuma continuano a stupire archeologi e visitatori. Il sito archeologico, parte del Parco dei Campi Flegrei, conserva l’antro della Sibilla Cumana, il tempio di Apollo, resti dell’anfiteatro, del circo e delle terme. Nel 1843, Lord Vernon scoprì un vasettino greco per unguenti con un’iscrizione arcaica che, tradotta, recita: “Io sono l’unguentario di Tataia: colui che mi avrà rubato, diventerà cieco” – una sorta di antico “sistema antifurto”!
Cuma era famosa anche per i suoi prodotti artigianali: i celebri vasi fittili chiamati “Calici Cumani” citati da Varrone, il pesce glauco cantato dal poeta Ennio, e persino i suoi cavoli, lodati da Columella per la loro squisitezza.
Un Patrimonio Eterno
La storia di Cuma è la storia della nascita della civiltà occidentale in Italia. Dalle sue mura uscì l’alfabeto che utilizziamo, dalla sua cultura nacque l’influenza greca che pervase la penisola. Visitare Cuma oggi significa camminare sui luoghi dove, 2.800 anni fa, iniziò il dialogo tra Oriente e Occidente che ha plasmato il nostro mondo.
Fonti:
- Minieri Riccio, C. (1846). Cenni storici sulla distrutta città di Cuma. Napoli: Tipografia di Vincenzo Priggiobba
- Enciclopedia Treccani – Cuma
- Wikipedia – Cumae
- Siti Archeologici d’Italia – Area archeologica di Cuma
- Wikipedia – Scavi archeologici di Cuma


Lascia un commento