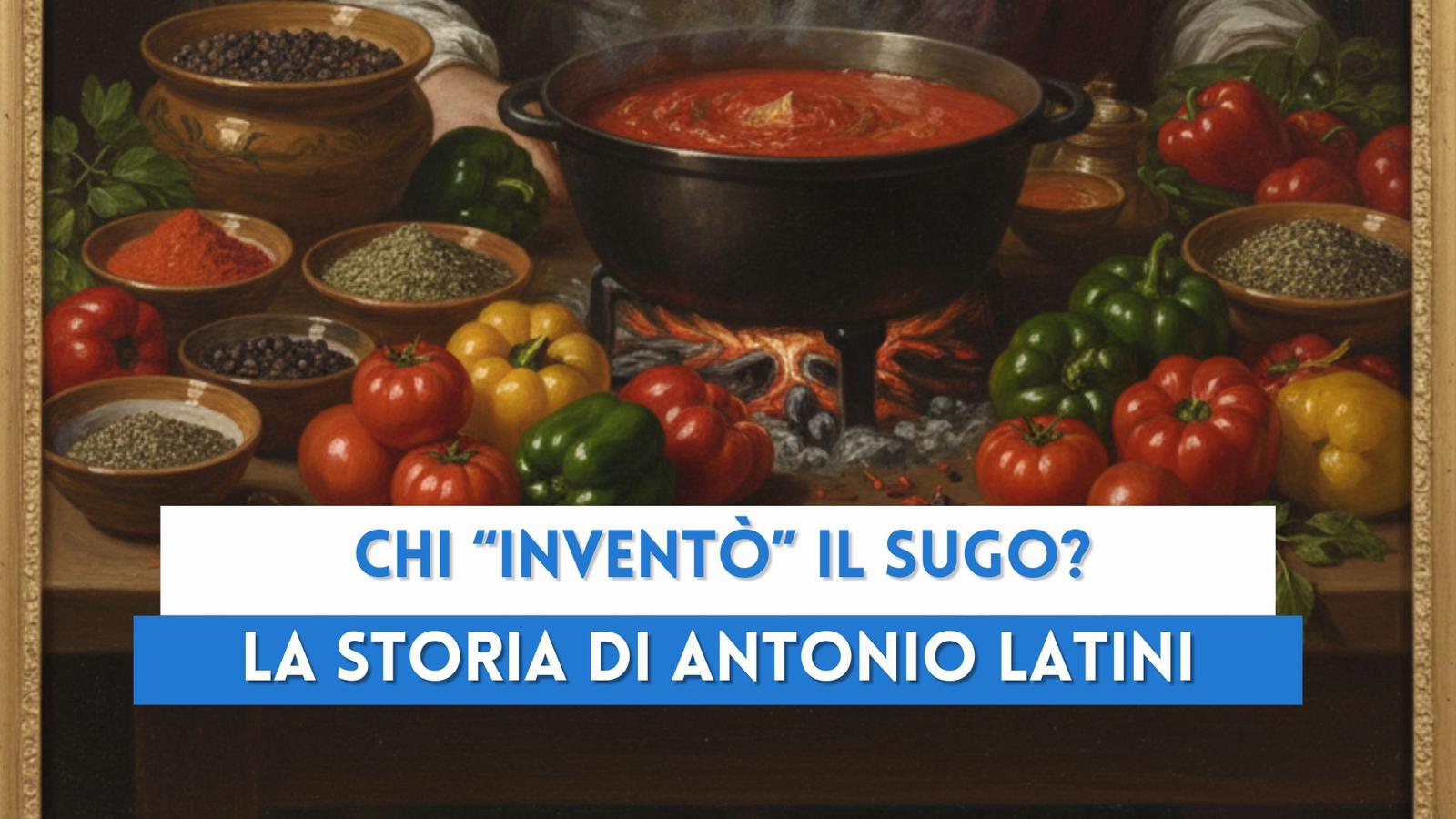Nel 1692, nelle cucine del palazzo del reggente spagnolo a Napoli, un cuoco marchigiano di cinquant’anni mise per iscritto una ricetta che avrebbe cambiato per sempre la storia della gastronomia mondiale. Si chiamava Antonio Latini, era nato orfano e povero a Fabriano, e quella ricetta era la “salsa di pomodoro alla spagnuola”: la prima preparazione a base di pomodoro mai pubblicata in un libro di cucina. Senza saperlo, Latini stava gettando le basi di quella che sarebbe diventata la vera cucina napoletana, e per estensione, di buona parte della cucina italiana che oggi tutto il mondo ci invidia.

Da orfano marchigiano a cavaliere napoletano
Antonio Latini nacque l’8 maggio 1642 a Colle Amato, presso Fabriano, nelle Marche. Rimasto orfano all’età di cinque anni, fu costretto a servire fin dalla più tenera età in cambio di un tetto sopra la testa e di che sfamarsi. Che fosse di umilissime origini lo sappiamo per certo, perché è stato recentemente ritrovato e pubblicato il manoscritto della sua autobiografia, dettata nel 1690 a un frate. È un documento prezioso che ci racconta la storia di un self-made man del Seicento, un uomo che dalla miseria più nera riuscì a conquistare ricchezza, fama e persino un titolo nobiliare.
A sedici anni, dopo aver imparato a leggere e a scrivere presso la nobile famiglia Razzanti di Matelica, Latini decise di tentare la fortuna emigrando a Roma. Era il 1658 e Roma era la capitale della cristianità, una città dove i cardinali vivevano come principi e i loro palazzi erano teatri di banchetti sontuosi che richiedevano eserciti di cuochi e servitori.
Latini venne assunto dal cardinale Antonio Barberini, nipote di papa Urbano VIII, come sottocuoco. Ma il giovane marchigiano era ambizioso e dotato: passò rapidamente a mansioni via via superiori, fino ad approdare, a soli ventotto anni, all’ufficio di scalco, ossia di soprintendente alle cucine. Era una posizione di enorme responsabilità: allo scalco spettava selezionare e dirigere i cuochi e la servitù, rifornire la dispensa, organizzare i banchetti, gestire i budget. In pratica, era l’equivalente di un moderno chef executive e manager di palazzo.
In casa Barberini, Latini imparò anche la difficile arte del trinciante (colui che tagliava le carni con maestria coreografica davanti agli ospiti), i modi del gentiluomo e persino a tirar di spada. Era un mondo raffinato e violento al tempo stesso, dove l’etichetta era fondamentale ma dove si doveva anche saper difendere l’onore.

Il percorso da Roma a Napoli
Dopo l’esperienza romana, Latini esercitò la scalcheria in diverse città: Macerata, Mirandola, Faenza. Erano tappe di un curriculum che lo stava portando sempre più in alto. Ma il coronamento della sua carriera arrivò quando venne chiamato a Napoli, alle dipendenze del reggente Esteban Carillo Salsedo, primo ministro del Viceré spagnolo.
Napoli, alla fine del Seicento, era una delle città più grandi e popolose d’Europa, capitale di un regno che si estendeva dall’Abruzzo alla Sicilia. Sotto il dominio spagnolo, aveva sviluppato una cultura gastronomica che mescolava tradizioni locali, influenze iberiche e il fascino per i prodotti esotici che arrivavano dal Nuovo Mondo. Era il luogo perfetto per un cuoco ambizioso come Latini.
Qui la sua fama crebbe enormemente. Qui fu insignito del titolo di cavaliere dello Speron d’oro, un riconoscimento pontificio che testimoniava quanto fosse salito in alto quel bambino orfano di Fabriano. E qui, negli ultimi anni della sua vita, compilò l’opera che lo avrebbe reso immortale: “Lo scalco alla moderna, o vero l’arte di ben disporre i conviti”.
Un’opera monumentale
Il libro venne pubblicato in due volumi tra il 1692 e il 1694 ed è un’opera ambiziosa e corposa, stampata senza badare a spese e illustrata da silografie e belle incisioni in rame. Come ha osservato lo storico della gastronomia Emilio Faccioli, “Lo scalco alla moderna” è «la summa di tutta la letteratura precedente, dagli esordi della gastronomia umanistica ai trattati maggiori dell’età rinascimentale».
Con la caratteristica mentalità dell’autodidatta – che non vuole lasciare indietro nulla di ciò che ha faticosamente appreso – Latini vi stivò tutto ciò che aveva accumulato in decenni di esperienze sul campo, letture e riflessioni. Il libro contiene:
- Considerazioni sui compiti dello scalco e dei suoi sottoposti, in particolare del trinciante
- Istruzioni sull’organizzazione della cucina e sulla preparazione dei banchetti
- Indicazioni su come imbandire le tavole e realizzare i “trionfi” (elaborate sculture commestibili che decoravano le tavole)
- Centinaia di ricette di arrosti, bolliti, stufati, fritti, brodi, minestre, pasticci, pizze, salse, aceti profumati, conserve
- Nozioni di dietetica e ricette di piatti di magro (per i giorni di digiuno)
- Ricette di sciroppi e sorbetti
- Un catalogo dettagliato dei prodotti gastronomici d’eccellenza e dei migliori vini del Regno di Napoli
La rivoluzione del pomodoro
Ma ciò che rende davvero prezioso “Lo scalco alla moderna” sono le notizie che Latini ci dà sui primi passi di quella che diventerà, nel giro di due secoli, la vera cucina napoletana. E il protagonista assoluto di questa rivoluzione è lui: il pomodoro.
Nel libro troviamo la ricetta della «salsa di pomodoro alla spagnuola», preparata con pomodori abbrustoliti sulle braci, cipolla, timo, “peparolo” (peperoncino), sale, olio e aceto. Latini scrive: “Pigliarai li pomidoro maturi, e li metterai a stufare sopra le brace, e come saranno abbrustolati li levarai la pelle, e li tagliarai molto bene con un coltello. Pigliarai cipolla tagliata a fette, e la metterai a soffriggere con un poco d’oglio, e la colorirari un pochettino, e vi metterai li pomidoro con sale, oglio, e aceto, e un poco di pepe, e spetieria a tuo piacimento”.
Non è solo la prima ricetta pubblicata di una preparazione a base di pomodoro, ma quella di un sugo che – come scrivono gli storici dell’alimentazione Alberto Capatti e Massimo Montanari – «con qualche aggiustamento sarà destinato a grande avvenire nella cucina italiana e nell’industria conserviera».
Il fatto che Latini chiami la salsa “alla spagnuola” è significativo: il pomodoro era arrivato in Europa dal Messico attraverso la Spagna, e gli spagnoli erano stati i primi a utilizzarlo in cucina. Ma è interessante notare come Latini, pur attribuendo la ricetta agli spagnoli, la stia già adattando al gusto napoletano, sostituendo in parte le spezie orientali con erbe aromatiche locali.
Il lungo viaggio del pomodoro
Per capire la portata rivoluzionaria di questa ricetta, bisogna conoscere la storia travagliata del pomodoro in Europa. Portato dal Nuovo Mondo dai monaci nel 1532 (il francescano Bernardino di Sahagún lo portò dalla Spagna), il pomodoro rimase per oltre un secolo un oggetto di studio per botanici e medici, ma non un alimento.
Era considerato bello ma non buono, addirittura velenoso da molti. Il suo stesso nome italiano – “pomo d’oro” per il colore giallo delle prime varietà giunte in Europa – ne sottolineava più l’aspetto ornamentale che quello culinario. Ci vollero generazioni perché gli europei superassero la diffidenza e iniziassero a mangiarlo.
La ricetta di Latini del 1692 segna quindi un punto di svolta: per la prima volta il pomodoro viene ufficialmente sdoganato come ingrediente nobile, degno di comparire nei banchetti delle corti e nei trattati dei grandi cuochi. Certo, quella “salsa alla spagnuola” era ancora lontana dal sugo di pomodoro che conosciamo oggi: era più una sorta di insalata di pomodori cotti che una vera salsa per condire la pasta. Ma era l’inizio.

Le altre innovazioni di Latini
Latini fu pioniere anche nell’impiego di un altro ortaggio del Nuovo Mondo: il peperone, che utilizza per insaporire alcune salse. Nel secondo volume del suo trattato, riservato interamente alle «vivande di magro», Antonio Latini sembra precorrere una tendenza che emergerà solo nella seconda metà del Settecento: la sostituzione delle spezie orientali (costose e considerate sempre più antiquate) con i profumi dell’orto.
Insegna infatti come «cucinare e condire vivande senza spezierie», impiegando al loro posto prezzemolo, timo serpillo e altre erbe odorose. È una rivoluzione silenziosa ma fondamentale: dalla cucina delle spezie esotiche si sta passando alla cucina dei sapori locali, dalle preparazioni elaborate a quelle più semplici e naturali.
La cucina napoletana nascente
Alla cucina partenopea rimandano i capitoli sui «diversi maccaroni, lasagne e gnocchetti» e sui frutti di mare. Latini dedica pagine appassionate alla pasta, che a Napoli stava diventando sempre più popolare. Non ancora con il pomodoro (quello sarebbe arrivato solo un secolo dopo), ma già con una varietà di condimenti che prefigurano la grande tradizione napoletana.
Alla più schietta tradizione partenopea si collegano anche le pagine sui sorbetti. Latini parla del sorbetto al limone con toni quasi lirici, descrivendo come prepararlo con neve (o ghiaccio) e “zuccaro”. I sorbetti napoletani erano già famosi in tutta Europa: la città aveva sviluppato una vera arte del freddo, grazie alla neve che veniva conservata in apposite neviere sul Vesuvio e trasportata in città.

L’atlante del gusto meridionale
Di grande interesse è, in appendice al primo volume dello “Scalco alla moderna”, l’atlante delle specialità enogastronomiche del Meridione. È un documento preziosissimo che ci mostra come molte eccellenze del Sud Italia fossero già riconosciute e apprezzate a fine Seicento.
Latini ci parla degli ortaggi di Chiaia (il quartiere elegante di Napoli), della frutta di Posillipo, dei cocomeri di Orta, delle olive di Gaeta, dell’olio d’oliva della Calabria e del Salento, dello zafferano dell’Aquila. Ci racconta dei capponi di Nocera, degli ovini del barese, dei pesci di mare del napoletano e di quelli d’acqua dolce di Avellino, delle ostriche di Taranto.
E ancora: le soppressate di Nola, i prosciutti abruzzesi e di Campobasso, i caciocavalli di Laterza, i confetti di Sulmona, il torrone di Aversa e di Benevento. È straordinario notare come queste specialità, a più di tre secoli di distanza, coincidano spesso con quelle attuali. Il territorio del Regno di Napoli aveva già sviluppato una geografia del gusto precisa e riconoscibile.
Napoli: crocevia di culture gastronomiche
La Napoli in cui Latini visse e lavorò era una città affascinante e contraddittoria. Capitale di un regno sotto dominio spagnolo, con una popolazione che superava i 200.000 abitanti (una delle città più grandi d’Europa), era un crogiolo di culture e tradizioni culinarie.
Le strade del centro storico brulicavano di venditori ambulanti che offrivano paste, pizza (ancora nella sua forma primitiva di focaccia), fritti di ogni tipo, frutti di mare. I nobili e i ricchi borghesi banchettavano nei loro palazzi con menu elaboratissimi, mentre il popolo si sfamava con cibi di strada economici ma gustosi. Gli spagnoli avevano portato nuovi ingredienti e nuove tecniche, che si mescolavano con le antiche tradizioni napoletane e con le influenze arabe rimaste dal Medioevo.
In questo contesto, Latini seppe cogliere il meglio di ogni tradizione. Da buon marchigiano, portava con sé la sobrietà e la concretezza del centro Italia. Dagli spagnoli aveva imparato l’uso di ingredienti esotici e una certa teatralità nei banchetti. Dai napoletani stava assorbendo il genio per i sapori semplici ma intensi, per la creatività popolare, per l’uso sapiente dei prodotti del mare e della terra.
L’eredità di un cuoco visionario
Antonio Latini morì a Napoli il 1° settembre 1696, a 54 anni. Non visse abbastanza per vedere il trionfo del pomodoro nella cucina italiana, ma aveva piantato il seme di quella rivoluzione. Dopo la sua morte, “Lo scalco alla moderna” continuò a essere letto e ristampato per decenni, influenzando generazioni di cuochi.
Solo nel 1808, più di un secolo dopo la pubblicazione della ricetta di Latini, Francesco Leonardi nel suo ricettario “Apicio Moderno” inserì per la prima volta il sugo di pomodoro in un vero piatto di pasta: i “Maccaroni alla Napolitana”. Da quel momento, la pasta al pomodoro iniziò la sua inarrestabile ascesa fino a diventare il simbolo stesso della cucina italiana nel mondo.
Ma senza Latini, senza quel cuoco orfano di Fabriano che ebbe il coraggio di mettere nero su bianco una ricetta “alla spagnuola” considerata esotica e un po’ strana, forse tutto questo non sarebbe mai accaduto. O sarebbe accaduto in modo diverso, più lento, meno luminoso.

Un territorio che parla ancora di lui
Per illustrare l’articolo si suggerisce di cercare su Wikimedia Commons immagini libere da copyright relative a:
Oggi, passeggiando per Napoli, è difficile non pensare a Latini. Il pomodoro è ovunque: nelle pizzerie, nelle trattorie, nei mercati dove si vendono i San Marzano DOP, nelle conserve artigianali, nei ristoranti stellati che reinterpretano la tradizione. Chiaia e Posillipo continuano a produrre ortaggi e frutta pregiati. Gaeta è ancora famosa per le sue olive. Il caciocavallo di Laterza, il torrone di Benevento, i confetti di Sulmona: tutto ciò che Latini elencava con orgoglio nel suo “atlante del gusto” è ancora lì, spesso con le stesse denominazioni d’origine protetta.
Il suo libro, “Lo scalco alla moderna”, è disponibile in edizioni moderne e in formato digitale su Wikisource. Gli storici della gastronomia lo studiano come fonte primaria per capire la transizione dalla cucina rinascimentale a quella moderna. I cuochi creativi vi trovano ispirazione per rivisitazioni contemporanee di ricette antiche.
Ma forse l’eredità più importante di Antonio Latini è più semplice e quotidiana: è in ogni piatto di pasta al pomodoro che mangiamo, in ogni pizza margherita, in ogni sugo che bollle nelle cucine di tutto il mondo. È nella consapevolezza che la grande cucina italiana non è nata per caso, ma è il frutto del lavoro di uomini e donne che, come Latini, hanno saputo guardare oltre le mode del loro tempo, sperimentare con coraggio, fondere tradizioni diverse.
Un orfano di Fabriano che divenne cavaliere a Napoli e che, con una semplice ricetta di pomodori abbrustoliti, cipolla, timo e olio, cambiò per sempre il modo in cui il mondo mangia. Questa è la straordinaria storia di Antonio Latini.
Riferimenti bibliografici e link
Fonti principali:
- “Antonio Latini”. In: Wikipedia. Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Latini
- Latini, Antonio. Lo scalco alla moderna, o vero l’arte di ben disporre i conviti. Napoli, 1692-1694. Disponibile su Wikisource: https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Antonio_Latini
Studi sulla gastronomia:
- Faccioli, Emilio (a cura di). L’arte della cucina in Italia. Torino: Einaudi, 1987
- Capatti, Alberto; Montanari, Massimo. La cucina italiana. Storia di una cultura. Bari: Laterza, 1999
- Camporesi, Piero. Il paese della fame. Milano: Garzanti, 1985
Sulla storia del pomodoro:
- “Salsa di pomodoro”. In: Wikipedia. Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Salsa_di_pomodoro
- “Pomodoro: storia, usi in cucina, benefici e varietà”. Enciclopedia Cucina GialloZafferano. Disponibile su: https://enciclopediacucina.giallozafferano.it/pomodoro
- Baresani, Camilla. “Quel pomodoro che ha creato la cucina a luci rosse – Storia del San Marzano”. CamillaBaresani.com, 6 maggio 2024
Sulla cucina napoletana:
- Francesconi, Jeanne Carola. La cucina napoletana. Newton Compton, 1995
- Sorrentino, Fernando. Storia della cucina napoletana. Napoli: Grimaldi, 2015
Articoli di approfondimento:
- “Latini – Sugo Al Pomodoro & Pastiera”. Museo della Cucina, 25 novembre 2022. Disponibile su: https://www.museodellacucina.com/latini-sugo-al-pomodoro-pastiera/
- “La Prima Volta Di Un Sugo Al Pomodoro”. Museo della Cucina, 25 aprile 2022
- “Pasta al pomodoro: ricetta e storia del piatto simbolo della cucina italiana”. Elior, 16 aprile 2025
- “Pomodoro, una storia lunga e travagliata”. Casa Artusi – Approfondimenti