Un dizionario magico nato dall’incontro tra sacro e profano
La smorfia napoletana è una sorta di “dizionario” in cui a ciascun vocabolo (persona, oggetto, azione, situazione, ecc.) corrisponde un numero da giocare al Lotto. Ma dietro questa semplice definizione si nasconde un universo culturale complesso che affonda le radici nella storia millenaria della Campania, dove tradizione popolare, spiritualità e speranza si intrecciano in modo indissolubile.
La Smorfia napoletana ha radici talmente antiche da non riuscire bene a collocarle nella storia; infatti, la ritroviamo già nella civiltà greca, quando Artemidoro da Daldi, cominciò a mettere in comunicazione i sogni con i messaggi ultraterreni nel suo “Libro dei sogni”. Tuttavia, è nel territorio campano che questo sistema di interpretazione ha trovato la sua forma più compiuta e popolare.
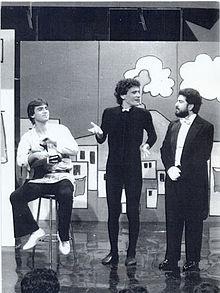
Dal mito di Morfeo alle strade di Napoli
L’origine del termine è incerta, ma la spiegazione più frequente è che sia legata al nome di Morfeo, il dio del sonno nell’antica Grecia. Il dio che nella mitologia greca plasmava i sogni dei mortali ha dato il nome a una tradizione che per secoli ha accompagnato la vita quotidiana dei napoletani.
Contrariamente a quanto molti pensano, la smorfia fece la sua comparsa prima a Genova nel 1539, poi in altre regioni (Marche, Sicilia e Romagna), approdando nel capoluogo campano solo agli inizi del ’600. Fu proprio in terra campana, però, che questo sistema si trasformò da semplice curiosità in fenomeno culturale di massa.
I numeri che hanno fatto storia
Alcuni numeri della smorfia sono diventati veri e propri simboli della cultura napoletana. Tra i più tipici abbinamenti numerici ci sono per esempio il 48 (morto che parla), 77 (le gambe delle donne), 25 (il Natale), 90 (la paura), 33 (gli anni di Cristo).
Il numero 47, “o muorto” (il morto), e il 48, “o muorto che parla” (il morto che parla), sono forse i più celebri. Non è un caso che il grande Totò abbia dedicato a quest’ultimo il titolo del suo celebre film del 1950 “47 morto che parla”. Il 90, “a paura”, ha dato origine al detto popolare “la paura fa 90”, espressione ormai entrata nel linguaggio comune di tutta Italia.
Un aspetto affascinante è la precisione con cui la smorfia distingue i contesti: per esempio “giocare” fa 79, ma cambia se si gioca ai cavalli (81), al lotto (33), a calcio (50), a carte (17), a scacchi (22). Questa attenzione al dettaglio rivela la profondità di un sistema che va ben oltre il semplice abbinamento casuale.
La tradizione orale che divenne libro
La smorfia, in origine, apparteneva alla tradizione orale, e solo in seguito fu trascritta su carta. Vista l’origine popolare della smorfia, non sono poche le edizioni della smorfia che associano i numeri alle immagini, a beneficio degli analfabeti. Questo dettaglio racconta molto della Napoli dei secoli passati, dove la cultura popolare doveva adattarsi alla realtà di una popolazione spesso priva di istruzione formale.
Nel Settecento e Ottocento, nelle strade di Napoli giravano venditori ambulanti che distribuivano “i pianeti della fortuna”: opuscoli illustrati con un pittoresco venditore che attirava la clientela esibendo un pappagallo dai colori sgargianti che pescava da un bussolotto, su richiesta, un foglietto con pronostici e numeri fortunati.

Le radici mistiche: dalla cabala al territorio campano
Secondo alcune teorie, si sospetta anche che la Smorfia possa essere ispirata alla Cabala ebraica, la quale fa uso dei numeri per svelare i significati reconditi della realtà apparente. La tradizione ebraica della qabbalah, che significa “dottrina ricevuta” o “tradizione”, incontrò in Campania un terreno fertile, mescolandosi con credenze popolari preesistenti.
Alcuni studiosi ipotizzano connessioni ancora più antiche: l’usanza di associare numeri a eventi potrebbe risalire al matematico e filosofo greco Pitagora di Samo (588-500 a.C.) e alla sua scuola numerologica di Crotone, in Magna Grecia. «Tutte le cose sono numeri», diceva infatti Pitagora: per il famoso filosofo di Samo i numeri erano delle vere e proprie entità materiali, con un significato magico.
Il matrimonio d’amore con il lotto
Tra la Smorfia e il Lotto c’è quello che solitamente viene definito “un matrimonio d’amore”, tant’è che è uso comune a Napoli, estrapolare i numeri da giocare proprio da eventi quotidiani o da ricordi di fatti attinenti al mondo dei sogni.
Le regole di questo “matrimonio” sono precise e rispettate religiosamente: quando i numeri vengono suggeriti dai sogni, è convenzione, ormai assodata, che le puntate debbano necessariamente essere “pure” senza l’aggiunta di altri estratti e che vadano seguite per le tre estrazioni successive. E guai a rivelare a chicchessia il “dono” ricevuto in sogno, pena l’annullamento della loro validità.
La smorfia nella cultura campana moderna
La smorfia ha conquistato anche il cinema e il teatro. Eduardo De Filippo la rese protagonista della sua commedia “Non ti pago” (1940), mentre Massimo Troisi, insieme a Lello Arena ed Enzo Decaro, chiamò il suo trio comico proprio “La Smorfia”. Troisi spiegò la scelta: “È un riferimento, tipicamente napoletano, a un certo modo di risolvere i propri guai: giocando al Lotto, e sperando in un terno secco […] la ‘smorfia’, infatti, non è altro che l’interpretazione dei sogni e dei vari fatti quotidiani, da tradurre in numeri da giocare a lotto”.
Memorabile è anche la scena dell’interpretazione dei sogni nel film “Così parlò Bellavista” di Luciano De Crescenzo, che ha reso celebre in tutta Italia l’arte napoletana di tradurre la vita in numeri.
Le tradizioni natalizie: dalla proibizione alla tombola
Una delle storie più affascinanti legate alla smorfia risale al 1734. Era l’anno 1734 e il re di Napoli Carlo III di Borbone era deciso ad ufficializzare nel suo Regno il gioco del Lotto che, se mantenuto in modo clandestino, avrebbe sottratto entrate alle casse dello Stato. A ciò si opponeva il frate domenicano Gregorio Maria Rocco.
Il compromesso raggiunto prevedeva la sospensione del gioco durante le festività natalizie. Ma ecco la geniale reazione popolare: i novanta numeri del lotto furono messi in “panarielli” di vimini e, per divertirsi in attesa della mezzanotte, ciascuno provvide a disegnare numeri sulle cartelle. Così la fantasia popolare riuscì a trasformare un gioco pubblico in un gioco familiare, che prese il nome di tombola.
I personaggi del territorio: l’“assistito” e i custodi della tradizione
Nella cultura campana esiste una figura particolare: l’“assistito”, una persona che si pone tra il reale e il soprannaturale. È colui che sa interpretare sogni ed eventi trasformandoli in numeri, spesso consultato nei quartieri popolari come una sorta di oracolo moderno.
Impossibile per un napoletano ricordare un Natale senza pensare agli affetti più cari riuniti intorno ad un tavolo per una bella tombolata, così come è difficilissimo dimenticare il nonno, lo zio o chicchessia che inizia a declamare i numeri dicendo: “Chest’è ’a mano ‘e chist’è ’o Panaro”. Queste scene familiari hanno tramandato per generazioni la conoscenza della smorfia.
La precisione dei significati: un codice complesso
La smorfia napoletana non è un sistema approssimativo. Ogni numero può avere molteplici significati a seconda del contesto: il famoso 48 non è solo “morto che parla”, ma può riferirsi anche all’avvocato, alla scimmia o al calcio. Allo stesso modo, il celebre 77 “le gambe delle donne” può essere abbinato ai diavoli, al vagabondo o al pagliaccio.
La tradizione vuole che gli elementi di un sogno complesso vengano analizzati separatamente per ottenere una sequenza di numeri combinabili, secondo un meccanismo preciso che porta alla creazione di una numerazione che contiene e concatena varie figure e molteplici casistiche della vita di tutti i giorni.
Un patrimonio culturale che resiste al tempo
Oggi la smorfia napoletana mantiene intatta la sua vitalità. Non è solo un retaggio del passato, ma continua a essere parte integrante della cultura campana. Dalle famiglie che si riuniscono per la tombola natalizia ai moderni giocatori di lotto che consultano app digitali, la smorfia attraversa le generazioni adattandosi ai tempi senza perdere la sua essenza.
La smorfia napoletana ha avuto un’influenza significativa sulla cultura e l’arte italiana, trovando posto in letteratura, cinema e teatro; essa rappresenta più di un semplice gioco di numeri, riflette la cultura, le superstizioni, l’umorismo e le tradizioni di Napoli e del popolo napoletano.
In una Campania moderna che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, la smorfia rappresenta uno dei più autentici esempi di come la tradizione popolare possa resistere al tempo, continuando a dare significato e speranza alla vita quotidiana delle persone.
Bibliografia e fonti:
- Serao, M. (1891). Il paese della Cuccagna. Milano: Treves
- De Filippo, E. (1940). Non ti pago. Commedia teatrale
- Liccardo, G. (2019). La smorfia napoletana: origine, storia e interpretazione. Newton Compton Editori
Fonti web:
- Wikipedia – La smorfia napoletana: https://it.wikipedia.org/wiki/La_smorfia_napoletana
- Poliorama – Come nasce la Smorfia Napoletana: https://www.poliorama.it/2022/12/23/come-nasce-la-smorfia-napoletana-le-origini-dalla-cabala-al-lotto/
- Smorfia Napoletana Web – I numeri da 1 a 90: https://smorfianapoletanaweb.it/smorfia-napoletana/
- Newton Compton Editori – La smorfia napoletana: https://www.newtoncompton.com/libro/la-smorfia-napoletana-origine-storia-e-interpretazione
- Napolinpillole – Smorfia napoletana numeri: https://www.napolinpillole.it/smorfia-napoletana-numeri/

