Introduzione
Nel febbraio del 1207, uno degli episodi più significativi della storia campana medievale ebbe luogo nei Campi Flegrei: la definitiva distruzione dell’antica città di Cuma per mano dei napoletani comandati da Goffredo di Montefuscolo.
Questo evento, che segnò la fine di una delle più antiche colonie greche d’Occidente, è indissolubilmente legato alla controversa figura del vescovo Gentile di Aversa, personaggio chiave nelle complesse dinamiche politiche e religiose del Regno di Sicilia all’inizio del XIII secolo.
Il Contesto Storico: L’Italia Meridionale tra Impero e Papato
L’anno 1207 si colloca in un periodo di grande instabilità politica nell’Italia meridionale. La morte dell’imperatore Enrico VI di Svevia nel 1197 aveva lasciato un vuoto di potere che generò una serie di conflitti tra sostenitori dell’autorità imperiale e fazioni papali. Il giovane Federico II, ancora minorenne, era sotto la tutela di papa Innocenzo III, mentre numerosi signori tedeschi, fedeli all’impero, continuavano a mantenere il controllo di importanti fortezze e territori nel Regno di Sicilia.
In questo scenario, la città di Napoli si era schierata dalla parte del papa, mentre molti nobili normanni e cavalieri tedeschi resistevano all’autorità pontificia. Tra questi ultimi emergeva la figura di Dipoldo von Schweinspeunt, conte di Acerra, che nonostante i decreti di espulsione continuava a esercitare un potere militare significativo in Terra di Lavoro.

Gentile: Un Vescovo tra Politica e Sopravvivenza
Le Origini e la Formazione
Gentile nacque intorno al 1150 da una famiglia della nobiltà cavalleresca di Aversa. La sua formazione religiosa avvenne nella scuola della cattedrale aversana, istituzione che rappresentava uno dei centri culturali più importanti della giovane diocesi, fondata appena un secolo prima, nel 1053, da papa Leone IX su richiesta dei governanti normanni.
L’Episcopato a Isernia e Venafro
Prima di giungere ad Aversa, Gentile aveva già sperimentato le turbolenze dell’epoca come vescovo di Isernia e Venafro dal 1192. Nel novembre dello stesso anno, la città di Venafro fu conquistata e saccheggiata dai cavalieri tedeschi al comando di Bertoldo di Kunig. Gentile, che probabilmente sosteneva Tancredi di Lecce, re di Sicilia, riuscì a sfuggire al saccheggio e si rifugiò ad Aversa, dove iniziò a manovrare per ottenere il controllo della diocesi locale.
L’Ascesa alla Cattedra Aversana
La morte del vescovo Lamberto di Aversa nel 1192 aveva lasciato vacante la cattedra episcopale. Gentile dovette attendere fino agli ultimi mesi del 1197 prima che papa Celestino III lo insediasse ufficialmente, probabilmente a causa delle tensioni politiche locali e del fatto che gli abitanti di Aversa parteggiavano per l’imperatore Enrico VI.
Le prime testimonianze documentali del suo episcopato aversano risalgono al febbraio 1198, quando l’imperatrice Costanza d’Altavilla, regina reggente di Sicilia, gli concesse privilegi significativi: le decime sul baiulato di Aversa, i proventi della tintoria cittadina e proprietà fondiarie nei dintorni della città.
L’Alleanza con Dipoldo di Acerra
La strategia politica di Gentile si caratterizzò per una notevole capacità di adattamento alle mutevoli circostanze. Nonostante inizialmente avesse ricevuto favori dall’autorità imperiale, verso il 1199 si avvicinò al conte Dipoldo di Acerra, che nel febbraio 1198 gli aveva donato un’isola nel lago di Lucrino.
Questa alleanza si rivelò problematica quando Gentile offrì supporto al conte contro i sostenitori del reggente pontificio in Terra di Lavoro. Nel 1203, persuase i cittadini di Aversa a sbarrare le porte della città e negare aiuto al conte Gualtieri di Brienne, alleato di papa Innocenzo III, giunto in Campania per una spedizione militare.
Il Processo Romano e le Conseguenze
L’operato di Gentile non passò inosservato alla Curia romana. Nel maggio 1204, un legato pontificio aprì un’indagine sui suoi rapporti con i cavalieri tedeschi banditi e sulla sua amministrazione ecclesiastica. Gli furono rimproverati cattiva gestione e sperpero di beni della Chiesa, tanto da essere citato davanti alla Curia romana il 6 luglio 1204.
Tuttavia, il processo non ebbe conseguenze severe. La morte di Gualtieri di Brienne nel giugno 1205, ferito in battaglia e fatto prigioniero dal conte Dipoldo, probabilmente indusse papa Innocenzo III a evitare misure troppo drastiche contro Gentile, preferendo mantenere un equilibrio precario piuttosto che inasprire ulteriormente la situazione.

La Spedizione di Cuma: Motivazioni e Contraddizioni
Le Condizioni di Cuma nel 1206
Verso il 1206, l’antica colonia greca di Cuma versava in condizioni di estremo degrado. Dopo essere stata devastata dai Saraceni nel 915 d.C., era diventata un rifugio per pirati e briganti che compivano scorrerie nel golfo di Napoli. La sua posizione strategica sull’acropoli, con le numerose gallerie sotterranee, offriva un rifugio sicuro per bande di predoni che terrorizzavano la regione.
Gli Obiettivi di Gentile
Gentile intraprese la spedizione contro Cuma con obiettivi multipli: sgominare le bande di briganti che vi si annidavano, accrescere le proprietà della Chiesa di Aversa e probabilmente ristabilire un’autorità ecclesiastica su un territorio che era stato sede vescovile fino al X secolo. La diocesi di Cuma, infatti, aveva una storia antica ma era ormai in stato di abbandono.
L’Alleanza Fallimentare con Goffredo di Montefuscolo
La collaborazione con Goffredo di Montefuscolo, nobile al servizio di Napoli, si rivelò problematica fin dall’inizio. Le fonti indicano che la reciproca diffidenza tra i due comandanti compromise l’efficacia dell’operazione militare. Questa tensione era probabilmente dovuta alle diverse motivazioni: mentre Gentile perseguiva obiettivi ecclesiastici e territoriali, Goffredo agiva per conto dell’autorità napoletana con finalità principalmente politiche e militari.

La Distruzione di Cuma: Febbraio 1207
La Spedizione Punitiva Napoletana
Nel febbraio 1207, i napoletani compirono una spedizione punitiva che devastò definitivamente la città di Cuma. L’operazione, condotta sotto il comando di Goffredo di Montefuscolo, aveva ufficialmente lo scopo di eliminare i pirati e briganti che usavano l’antica città come base per le loro scorrerie.
La Drammatica Fuga di Gentile
Gentile si trovava a Cuma quando i napoletani attaccarono la città. Il vescovo scampò a malapena all’incendio della torre nella quale si era asserragliato con il suo seguito. Questo episodio dimostra quanto fosse pericolosa la situazione e come la spedizione avesse assunto caratteri di estrema violenza.
Le Conseguenze Ecclesiastiche
La distruzione di Cuma ebbe immediate ripercussioni sull’organizzazione ecclesiastica della regione. Il vescovato di Cuma, soppresso in questa circostanza, passò con la sanzione pontificia all’arcivescovo di Napoli, mentre il territorio episcopale fu diviso tra le diocesi di Aversa e Pozzuoli.
Nel 1215, il legato imperiale Lupoldo, vescovo di Worms, concesse il castello distrutto di Cuma alla Chiesa di Aversa, rappresentando una sorta di risarcimento per Gentile e la sua diocesi.
L’Eredità di Santa Giuliana e il Trasferimento del Culto
Il Rifugio a Giugliano
Numerosi cumani fuggiaschi trovarono ospitalità a Giugliano insieme al clero e al capitolo cattedrale, che trasferì le reliquie e il culto dei santi protettori. Questo trasferimento di popolazione e tradizioni religiose ebbe conseguenze durature per la storia del territorio atellano.
La tradizione vuole che in questa circostanza il culto di Santa Giuliana, precedentemente venerata a Cuma, si stabilisse definitivamente a Giugliano. La santa divenne patrona della città e la sua venerazione si estese ad altri centri limitrofi, tra cui Frattamaggiore.
L’Insediamento a Friano
I profughi cumani che si stabilirono a Giugliano si concentrarono inizialmente nel luogo chiamato “Friano”, in quello che diventerà il feudo di Deganzano. Qui, alla fine del XVI secolo, sorgerà un convento dei frati Cappuccini, utilizzando i resti di una chiesa parrocchiale dedicata a Santa Giuliana.
Gli Ultimi Anni di Gentile e la Sua Eredità
Il Miracolo di Maria Salomè
Nell’estate del 1209, Gentile informò il papa di guarigioni miracolose verificatesi ad Aversa dopo il ritrovamento delle reliquie di Maria Salomè, evento che, secondo la letteratura agiografica, avvenne quello stesso anno a Veroli. Questo episodio rivela i rapporti mantenuti tra il vescovo e la Curia romana nonostante le precedenti controversie.
La Scomparsa dalle Fonti
Dopo il 1210, Gentile non è più menzionato nelle fonti storiche. Non è noto se fosse ancora vivo quando Aversa fu assediata per due volte dall’imperatore Ottone IV nel 1210-11. Il suo successore, Basuino, è attestato solo a partire dal luglio 1215.
Valutazioni Storiche e Considerazioni Conclusive
Un Uomo del Suo Tempo
La figura del vescovo Gentile va inserita nel contesto delle complesse dinamiche politiche dell’epoca. La sua capacità di navigare tra le diverse fazioni – impero, papato, nobiltà normanna, cavalieri tedeschi – dimostra una notevole abilità politica e una chiara comprensione della necessità di preservare gli interessi della giovane diocesi di Aversa.
L’Importanza dell’Episodio di Cuma
La distruzione di Cuma del 1207 rappresenta uno spartiacque nella storia dei Campi Flegrei. La fine dell’antica colonia greca, fondata nell’VIII secolo a.C., segnò la chiusura di un capitolo millenario della storia mediterranea. Contemporaneamente, il trasferimento del culto e delle tradizioni cumane nel territorio atellano contribuì a forgiare l’identità religiosa e culturale di comunità come Giugliano e Frattamaggiore.
L’Eredità Istituzionale
Nonostante le controversie che caratterizzarono il suo episcopato, Gentile riuscì nell’obiettivo principale: garantire la sopravvivenza e il consolidamento della diocesi di Aversa. L’acquisizione del territorio cumano, formalizzata nel 1215, rappresentò un significativo ampliamento dei possedimenti ecclesiastici aversani.
La sua strategia, pur apparendo opportunistica, si rivelò efficace nel lungo periodo. La diocesi di Aversa non solo sopravvisse alle turbolenze del periodo, ma si consolidò come una delle istituzioni ecclesiastiche più importanti della Campania settentrionale.
L’Impatto sulla Memoria Storica Locale
L’episodio della distruzione di Cuma e il ruolo di Gentile continuano a influenzare l’identità storica delle comunità dell’area atellana. La tradizione del culto di Santa Giuliana, il ricordo dei profughi cumani e la memoria delle antiche istituzioni ecclesiastiche rappresentano elementi fondamentali del patrimonio culturale locale.
La storiografia moderna ha spesso trascurato figure come quella di Gentile, considerate “minori” rispetto ai grandi protagonisti dell’epoca. Tuttavia, è proprio attraverso l’analisi di questi personaggi che possiamo comprendere meglio le dinamiche locali e la complessità delle trasformazioni che caratterizzarono l’Italia meridionale nel passaggio dal periodo normanno a quello svevo.
Fonti e Bibliografia
Fonti Primarie e Studi Specialistici
- Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, voce “Gentile” (vescovo di Aversa)
- Archivio Storico per la Calabria e la Lucania, Atti e Memorie della Società Magna Grecia
Fonti Istituzionali
- Diocesi di Aversa – Storia istituzionale (https://www.diocesiaversa.it/storia/)
- Cathopedia – Diocesi di Aversa (https://it.cathopedia.org/wiki/Diocesi_di_Aversa)
- Ministero della Cultura – Parco Archeologico dei Campi Flegrei (https://cultura.gov.it/luogo/parco-archeologico-dei-campi-flegrei-parco-archeologico-di-cuma)
Studi Locali e Territoriali
- Parco Archeologico Campi Flegrei – Cuma (http://www.pafleg.it/it/4382/cuma)
- Campi Flegrei Online – Casina Vanvitelliana (https://www.campiflegreionline.it/Casina_Vanvitelliana.html)
- Alta Terra di Lavoro – Cuma e la Sibilla Cumana (https://www.altaterradilavoro.com/cuma-e-la-sibilla-cumana-cuma-and-sibyl-of-cuma/)
Fonti Enciclopediche
- Wikipedia – Diocesi di Aversa (https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Aversa)
- Wikipedia – Cuma (https://it.wikipedia.org/wiki/Cuma)
- Summa Gallicana – Cuma (https://www.summagallicana.it/lessico/c/Cuma.htm)
Archivi Locali
- Archivio Giulianese – Il vescovo Gentile, Santa Giuliana e la distruzione di Cuma (https://archiviogiuglianes.wixsite.com/website/post-singolo/2020/03/10/il-vescovo-gentilesanta-giuliana-e-la-distruzione-di-cuma)
Articoli Giornalistici e Divulgativi
- Il Mattino – “Tesori di Cuma, spunta un Cristo del Medioevo” (30 settembre 2024)
- Acqua Campania SpA – Giugliano in Campania, cenni storici (24 ottobre 2016)

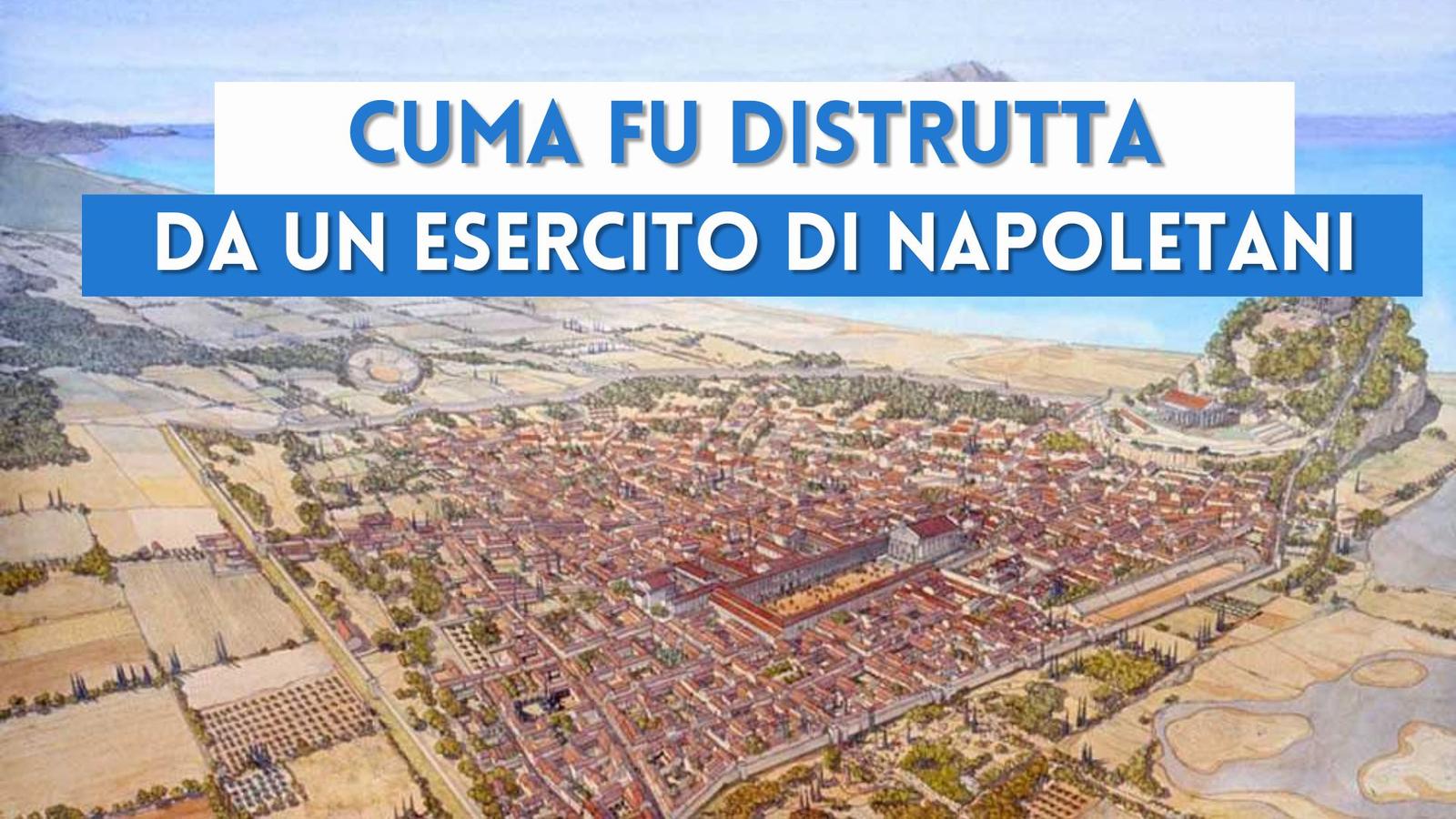
Lascia un commento