Quando si parla di storiografia del Mezzogiorno, un nome emerge con particolare autorevolezza: Giuseppe Galasso. Nato a Napoli nel 1929 da una famiglia di modeste origini – il padre era un artigiano del vetro – la sua storia personale riflette quella di tanti napoletani del Novecento, segnati dalla guerra e dalla necessità di riscattarsi attraverso lo studio.
Un napoletano verace tra le pagine della storia
La vita di Galasso inizia nei vicoli di Napoli, dove da ragazzo fa “un po’ di tutto, anche il garzone di cucina e il portiere” per aiutare la famiglia dopo aver perso la madre nel 1941. Un dettaglio che racconta molto del carattere del futuro storico: quella capacità di sporcarsi le mani, tipicamente napoletana, che lo accompagnerà per tutta la carriera accademica.
Il giovane Giuseppe si diploma al liceo Umberto I da privatista nel 1947, poi si laurea in storia medievale all’Università Federico II. Una scelta non casuale: Napoli e il suo territorio saranno il fulcro dei suoi studi per tutta la vita. Ma non è stato amore a prima vista con l’accademia. Prima di diventare il celebre professore universitario, Galasso ha vissuto sulla propria pelle le contraddizioni del Mezzogiorno che poi avrebbe studiato con tanta lucidità.

Il territorio come laboratorio di ricerca
La peculiarità di Galasso sta nell’aver fatto del territorio meridionale non solo un oggetto di studio, ma un vero e proprio laboratorio di ricerca storica. Le sue opere più famose – “Economia e società nella Calabria del ‘500” e “Napoli spagnola dopo Masaniello” – nascono da un approccio innovativo: non studiare la storia “dall’alto”, dai palazzi del potere, ma “dal basso”, dalle dinamiche sociali ed economiche che si sviluppavano nei territori.
Prendiamo la Calabria del Cinquecento: mentre altri storici si concentravano sulle grandi vicende politiche, Galasso analizzava come vivevano i contadini, come funzionavano i mercati locali, quali erano i rapporti tra proprietari terrieri e braccianti. Un approccio che oggi chiamiamo “microstoria”, ma che negli anni ’60 era rivoluzionario.
Tra cattedra e palazzo: lo storico-politico
Esponente del Partito repubblicano italiano, Galasso fu sindaco di Napoli nel 1975 e deputato dal 1983 al 1994. Ma il suo impegno politico più significativo riguarda la tutela del paesaggio. Come sottosegretario ai Beni culturali, promosse la celebre “legge Galasso” del 1985, che ancora oggi protegge il nostro patrimonio paesaggistico.
Un aneddoto curioso: durante i lavori parlamentari per la legge, Galasso utilizzava le sue conoscenze storiche per convincere i colleghi deputati. Raccontava come nei secoli passati la bellezza del paesaggio italiano avesse attirato viaggiatori da tutta Europa, creando quello che oggi chiameremmo “turismo culturale”. La storia, insomma, come argomento per il presente.
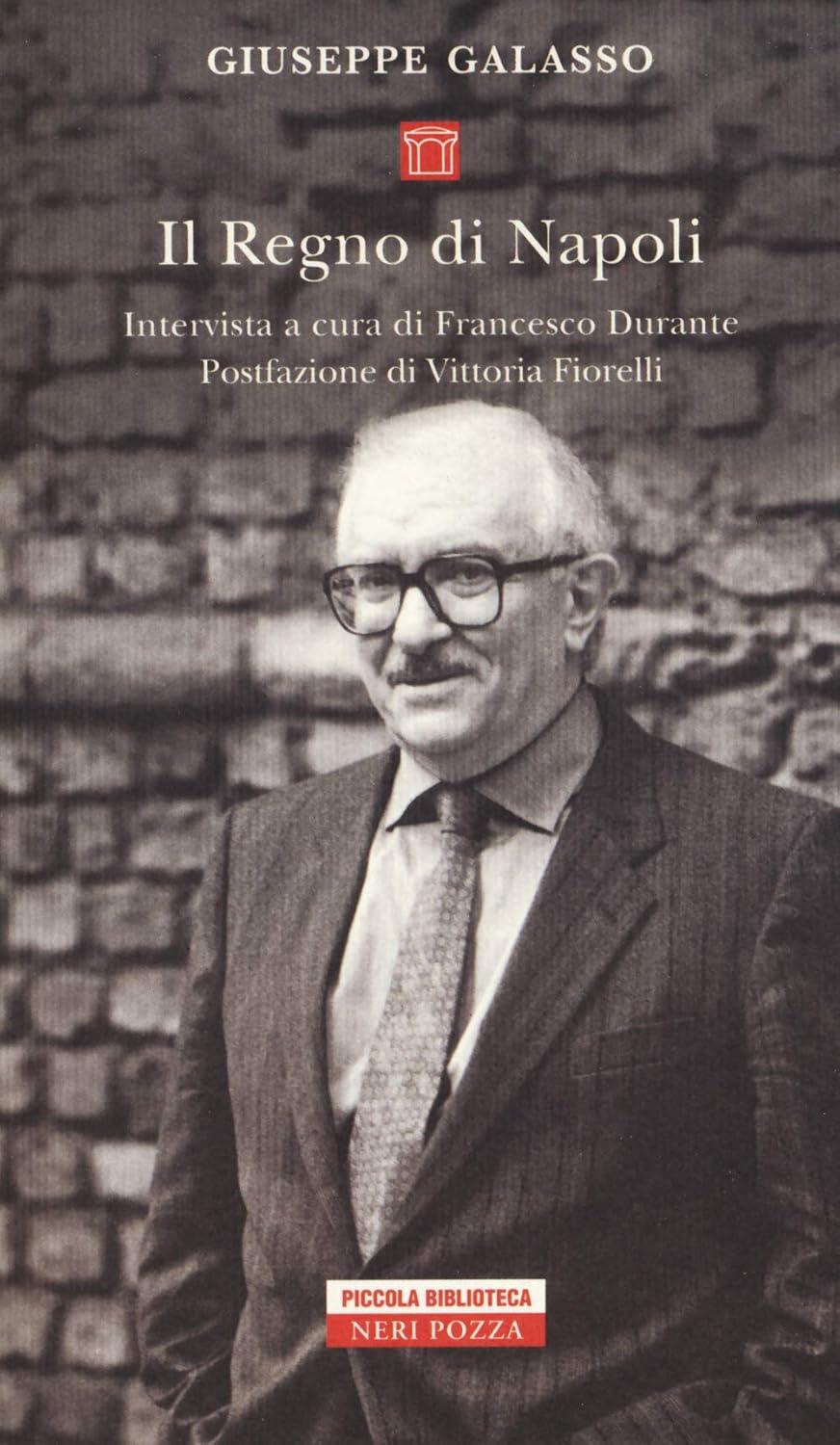
Uno dei libri più interessanti di Giuseppe Galasso. Puoi comprarlo qui.
Il maestro e i suoi allievi
All’Università Federico II, Galasso ha formato generazioni di storici. La sua “scuola” napoletana era famosa per il metodo rigoroso ma anche per l’atmosfera familiare. Come ricorda l’Università di Napoli, è stato “maestro di giovani studiosi, che alla sua scuola si sono formati”.
I suoi seminari erano leggendari: Galasso arrivava sempre con una cartellina di cuoio logora, piena di appunti scritti a mano. Non usava mai il computer, preferiva la penna stilografica. Aveva l’abitudine di fermarsi a metà lezione per accendere la pipa e in quel silenzio nascevano spesso le domande più interessanti degli studenti.
L’eredità intellettuale
Presidente della Biennale di Venezia, promotore della “legge Galasso” per la protezione del paesaggio e accademico dei Lincei, Galasso ha lasciato un’eredità che va oltre i suoi libri. Ha dimostrato che si può essere storici autorevoli rimanendo legati al proprio territorio, anzi traendo da questo legame la forza per interpretazioni originali.
La sua “Intervista sulla storia di Napoli” rimane un capolavoro di divulgazione storica, capace di raccontare secoli di vicende napoletane con la freschezza di chi quelle strade le ha percorse davvero. Quando parlava della Napoli spagnola o di quella borbonica, sembrava di sentire un testimone oculare piuttosto che uno storico.
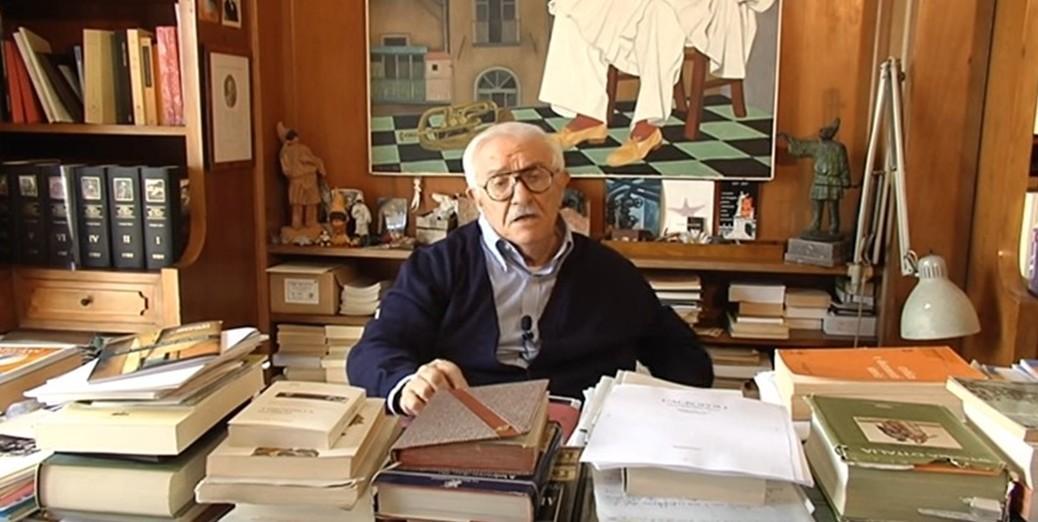
Uno sguardo al presente
Scomparso nel 2018, Giuseppe Galasso ci ha lasciato una lezione fondamentale: la storia non è un esercizio accademico astratto, ma uno strumento per comprendere il presente. I suoi studi sul Mezzogiorno medievale e moderno ci aiutano ancora oggi a capire le radici profonde delle questioni meridionali contemporanee.
In un’epoca in cui spesso si cerca di semplificare la complessità del Mezzogiorno, l’opera di Galasso ci ricorda che la storia di questi territori è ricca, stratificata, piena di contraddizioni ma anche di straordinarie potenzialità. Una lezione di metodo e di passione civile che continua a ispirare studiosi e cittadini.
Bibliografia e fonti
- Enciclopedia Treccani, voce “Galasso, Giuseppe”: https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-galasso/
- Università di Napoli Federico II, “Addio a Giuseppe Galasso, storico e politico napoletano”: https://www.old.unina.it/-/15909352-addio-a-giuseppe-galasso-storico-e-politico-napoletano
- Intervista sulla Storia di Napoli: https://amzn.to/3IWZvWA
- Wikipedia, “Giuseppe Galasso”: https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Galasso
- Laterza Editori, “Intervista sulla storia di Napoli”: https://www.laterza.it/scheda-libro/?isbn=9788858134771
- Centro di ricerca “Guido Dorso”: http://www.centrodorso.it/la-questione-meridionale-oggi-giuseppe-galasso/

